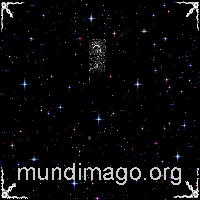Arte e storia
La parola Storia ha un etimo interessante, perché vi si
trovano radici indeuropee ricche di significato. C'è qualcosa del verbo
vedere, che è anche una capacità dell'intelletto di
riconoscere e
giudicare, e quindi di
sapere.
La Storia è la grande maestra che insegna. O almeno dovrebbe. E la
Storia, nella personificazione antica, era una Musa, figlia di Zeus
tonante, esattamente Clio, 'colei che rende celebre' e che con le
sorelle abitava l'illustre casa, il Museion.
I
Musei della Storia sono luoghi dove si celebra (nel senso stretto di
frequentazione) il Passato. Un rapporto fruttuoso per il futuro, se è vero che proprio da "ciò che fu" si inizia a imparare.
Ci
sono alcuni musei, nel mondo, che hanno lo scopo precipuo di coltivare e
rinnovare la Memoria. Il prossimo 27 gennaio ricorre il
Giorno della Memoria delle vittime dell'Olocausto, tragedia umanitaria che ogni anno viene ricordata in Italia e nel mondo.
Alla memoria dello sterminio nazista e del popolo ebraico sono dedicati molti musei in tutto il mondo. Ci sono città, come
Varsavia e soprattutto
Cracovia,
dove ancora - nelle zone meno turistiche e frequentate, negli anfratti
delle fabbriche, lì dove Oskar Schindler nascondeva i suoi operai -
aleggia la ferocia e la crudeltà. Ci sono muri, negli antichi ghetti,
ancora imbrattati, a memento del passato. Poi ci sono città che, per una
serie di legami con la Shoah, decidono di dedicare allo sterminio un
luogo di perpetua memoria. Un
museo: nel senso di
casa della storia.
Due, almeno, da vedere. Il primo è il
Yad Vashem di Gerusalemme, creato dall'architetto israelo-americano
Moshe Safdie e inaugurato nel 2005 dopo 10 anni di lavori.
Il
Museo è formato da un colossale prisma di 180 metri di lunghezza;
all'interno in un percorso a zig zag, gallerie disposte cronologicamente
rappresentano, una dopo l'altra, le fasi storiche dell'ebraismo
europeo. Il Mevoah, un ipogeo a sezione triangolare in cemento armato,
lungo 200 metri e alto 18, è il cardine della composizione e attraversa
la sommità del colle Yad.
Il percorso inclinato dà l'impressione di una discesa
ad inferos,
di calarsi all'interno di una montagna; le pareti laterali convergono
verso l'alto da dove, debole e fioca, proviene la luce. "Ho avuto l'idea
che le gallerie dove sarebbe stata narrata la storia dell'Olocausto
sarebbero state come dei resti archeologici o scavi nella roccia
naturale".
Si arriva, alla fine, nella
Stanza dei nomi/Hall of Names, un cono di dieci metri che raccoglie testimonianze e lettere delle
vittime conosciute dell'Olocausto; simmetricamente, sotto terra, un altro cono è dedicato alle
vittime senza un nome.
Il secondo è Il
Museo Ebraico di Berlino creato da
Daniel Libeskind.
Anche
nella costruzione di Libeskind, del 2001, ha una nota zigzagante: se a
Gerusalemme è il percorso nella storia a essere disorientante, qui è la
struttura che, fortemente simbolica, ricorda una saetta o la stella di
Davide distorta.
Così la struttura, che taglia la Lindenstraße, perde ogni funzionalità di contenitore ma diventa essa stessa
metafora della sorte di un popolo e, come tale, arte. La
concettualizzazione della Shoah nel progetto di Daniel Libeskind è inequivocabile.
Il
percorso interno segue la storia, e ne vive le emozioni: come l'altro
non affronta l'Olocausto linearmente, il percorso crea le condizioni
emotive per una immedesimazione tra lo spettatore e la tragedia. L'arte
il questo caso, non è rappresentata dall'oggetto che si vede, si tratta
di documenti che come tali (=doceo) insegnano. L'arte è il contenitore,
che porta alla compassione, alla comprensione profonda della tragedia.
Una
tragedia senza redenzione finale: il percorso del Museo di Berlino si
chiude con l'alienazione dell'essere umano, al buio e lontano dal mondo.
La
tragedia ha tante forme per essere narrata. Voci che si tramandano,
forme che non si deteriorano e rimangono ferme a monito delle
generazioni future. Voci che diventano arte, forse perché solo
l'arte può rendere liberi.-
.

.
.
.
.
-