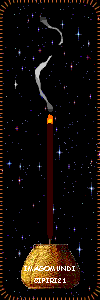S’è chiusa quella Bocca
«Tutti
quelli che fanno il giornalismo lo fanno sperando di dire la verità:
anche se è difficile, li esorto e li incoraggio a continuare su questa
strada». Un testamento ideale quello che Giorgio Bocca, firma storica
del giornalismo italiano, scomparso all'età di 91 anni, affidò alle
nuove generazioni nell'aprile 2008, ricevendo nella stessa casa di
Milano dove si è spento dopo una breve malattia, il premio Ilaria
Alpi alla carriera. Un testamento anche il titolo del libro che uscirà
l'11 gennaio per Feltrinelli, «Grazie no. 7 idee che non dobbiamo più
accettare». Insomma Bocca rimane l'Antitaliano, come si chiamava la sua
celebre rubrica sull'Espresso, fino all'ultimo giorno. La ricerca della
verità, accompagnata dal rigore analitico, dalla passione civile, da uno
stile fatto di sintesi e chiarezza e fortemente segnata dal suo
carattere, un mix di disciplina sabauda, curiosità severa e vis
polemica: questi i valori che hanno ispirato la carriera più che
cinquantennale di Bocca. Valori che il giornalista e scrittore, medaglia
d'argento al valor militare, aveva vissuto fino in fondo soprattutto
nei primi anni di attività, quelli della guerra e della militanza
partigiana: «I giornalisti della mia generazione - sottolineò in una
delle sue ultime apparizioni in tv, ospite a Le invasioni barbariche su
La7 nel novembre 2008 - erano mossi da un motivo etico: ci eravamo messi
tragedie alle spalle, perciò il nostro era un giornalismo abbastanza
serio. Oggi la verità non interessa più a nessuno» e «l'editoria è
sempre più al servizio della pubblicità». Nato a Cuneo da una famiglia
della piccola borghesia piemontese nel 1920, iscritto alla facoltà di
Giurisprudenza, appassionato di sci agonistico - e perciò noto
nell'ambiente del Guf (la gioventù universitaria fascista) cuneese -
Bocca iniziò a scrivere già a metà degli anni 30, su periodici locali e
poi sul settimanale cuneese La Provincia Grande. Durante la guerra si
arruolò come allievo ufficiale di complemento fra gli alpini e dopo
l'armistizio fu tra i fondatori delle formazioni partigiane di Giustizia
e Libertà: «L'ho fatto per pagarmi il biglietto di ritorno alla
democrazia», spiegava. Riprese allora l'attività giornalistica,
scrivendo per il quotidiano di GL, poi per la Gazzetta del Popolo, per
l'Europeo e per Il Giorno e segnalandosi per le inchieste. Nel 1976 fu
tra i fondatori, con Eugenio Scalfari, del quotidiano la Repubblica, con
cui aveva continuato a collaborare fino alle ultime forze. Al suo
attivo anche numerosi libri, che spaziano dall'attualità politica e
dall'analisi socioeconomica all'approfondimento storico e storiografico,
dalla questione meridionale alle interviste ai protagonisti del
terrorismo, senza mai dimenticare la sua esperienza partigiana, in nome
della quale aveva anche polemizzato di recente con alcuni tentativi di
revisione critica della Resistenza e in particolare con Giampaolo Pansa.
Tra i titoli più noti di Bocca, Storia dell'Italia partigiana (1966);
Storia dell'Italia nella guerra fascista (1969); Palmiro Togliatti
(1973); La Repubblica di Mussolini (1977); Il terrorismo italiano
1970-78 (1978); Storia della Repubblica italiana - Dalla caduta del
fascismo a oggi (1982); l'autobiografia Il provinciale. Settant'anni di
vita italiana (1992); L'inferno. Profondo sud, male oscuro (1993);
Metropolis (1994); Italiani strana gente (1997); Il secolo sbagliato
(1999); Pandemonio (2000); Il dio denaro (2001); Piccolo Cesare (2002,
dedicato al fenomeno Berlusconi, libro che segnò il passaggio di Bocca
da Mondadori, suo editore da oltre dieci anni, a Feltrinelli); Napoli
siamo noi (2006); Le mie montagne (2006); È la stampa, bellezza (2008).
Annus Horribilis, Milano, Feltrinelli (2010). Fratelli Coltelli
(1948-2010 L'Italia che ho Conosciuto), Milano, Feltrinelli (2010).
Nella vita di Bocca c'è stato spazio anche per una breve esperienza
televisiva su Canale 5, alla fine degli anni '80, con la rubrica I
protagonisti. «Quando andai a lavorare a Canale 5 - raccontò in
un'intervista - Scalfari disse 'Giorgio si è innamorato di Berlusconì. E
in effetti mi piaceva la sua capacità di fare la tv sul piano tecnico e
organizzativo. Ma quando si mise a far politica, cambiai idea». Con
l'abituale lucidità, così sintetizzava la sua biografia politica: «Sono
uscito dal fascismo, sono entrato nella Resistenza a capo di una
divisione partigiana di Giustizia e libertà e poi, pur essendo stato
vicino al Psi non mi sono più iscritto ad alcun partito: non ho più
voluto avere uno che decidesse sulla mia testa». Alle elezioni del 2008
non aveva neanche votato: «Mi ha stufato la politica com'è in Italia».
.
.
.
Montanelli e Bocca 1978
Lezioni di giornalismo in ricordo di due grandi penne italiane
.
“Match”, Rai, fine anni settanta: coordina il dibattito Alberto
Arbasino, ospiti Indro Montanelli e Giorgio Bocca. Arbasino vuole lo
scontro, l’urto, la discussione accesa; ne va degli ascolti. Ma
Montanelli e Bocca non litigano: parlano. Per l’italiano medio quello
spettacolo è noioso, poiché non ne conosce lo stile. Colpi da biliardo e
non di clava. Lavoro minuzioso con scalpello e martellino per solcare
il muro al millimetro, criterio più elegante che si estranea dal
contesto generale, in cui la ferramenta è composta da una palla
d’acciaio attaccata a un gru. E che scompone con gran boato tutto quello
che tocca; distruggendo e non creando. Il botta e risposta col
fioretto, il fazzoletto al taschino e la buona educazione non piace alla
gente. Arbasino lo sa: “scusate, ma ho l’impressione che il nostro
civile incontro di stasera sia talmente civile che è di una
pacatezza….”. lo interrompe Bocca: “guarda Arbasino che io non sono
venuto qui per far finta di litigare con Montanelli. La televisione è
bella e interessante, ma io non sono qua per far divertire la gente”. Se
ne va portandosi nella tomba quel modo pacato di fare giornalismo. Ora
–se si vuole escludere Scalfari- tutti i grandi narratori del’900 se ne
sono andati: da Longanesi a Biagi, da Montanelli a Bocca, passando per
Flaiano che, raccontando alla perfezione gl’italiani, ha compilato
cent’anni di fatti, di notizie, di articoli giornalistici con la data in
bianco. Attuali in qualunque momento. Piangere un uomo di novantun anni
è roba da idioti; ma lo è ancora di più non cogliere questa occasione,
l’ultima notizia che da Bocca ci giunge: è morto, e la sterminata sua
opera è a disposizione. Libri, articoli, apparizioni tv, intuizioni
celeberrime che, come additava ad Arbasino, non avevano come scopo il
“far divertire la gente”. Bocca non raccontava i pregi degl’italiani.
Che sono pochi. Ma i loro difetti: che sono molti. E, come un buon
amico, fino all’ultimo, non ha perso tempo con stupide lodi; ma con
costruttivi rimproveri. Se la prendeva con gl’italiani e coi loro
difetti endemici: banalità, furbizia, ignoranza. È stato il più sincero
di tutti. Né un finto amico né un finto nemico. Come lo raccontava
Montanelli nei suoi diari.
16 novembre 1969; Mi riferiscono, di Bocca, questo giudizio su di me:
“Sempre il più bravo di tutti. Bravissimo. Troppo bravo. Ma mettendo lo
stesso impegno a scrivere gli articoli su Venezia e quello sull’arbitro
Lo Bello, dimostra che in realtà non è impegnato in nulla”. È vero. Non
sono impegnato in nulla. In nulla, meno che nel mio mestiere.
Fiorentina-Bari 3-0. E Chiarugi capo-cannoniere.
25 novembre 1969; Solo ora mi mostrano l’articolo che Bocca mi ha
dedicato sul Giorno. Gli avevo mandato la mia Italia del Seicento con
una dedica affettuosa in cui lo chiamavo “ami-nemico”. Lui ne informa i
lettori, ma mi risponde da nemico dichiarato, con una stroncatura
sgarbata. Non vorrei cadere in peccato di presunzione. Ma credo che sia
stato per differenziarsi da me, per non diventare una mia copia, che si è
costruito un personaggio antitetico al mio: eternamente impegnato,
intransigente, accigliato, e costretto a una perpetua polemica con tutto
ciò che io rappresento. Ma anche lui ne capisce l’artificiosità ed
evita il contatto con me perché teme che lo costringa a prenderne atto.
Se potesse, mi sopprimerebbe. Eppure, sono io a sentirmi colpevole verso
di lui che, senza di me, sarebbe diventato un grande, un grandissimo
giornalista, e non soltanto un inquisitore, molto spesso sbagliato.
25 giugno 1970; Apro per caso la radio, e sento la voce di Bocca: “Io
non sono un ipocrita come Montanelli, il quale va ripetendo che scrive
per il lettore. Io il lettore non lo conosco, e non m’interessa. Scrivo
solo per i pochi amici che stimo, fra i quali c’è anche lo studente
Capanna (Mario Capanna, leader del movimento studentesco n.d.r.),
sebbene non lo abbia mai incontrato. E scrivo solo quello che piace a me
e a loro…”. Non si rende conto di quale omaggio mi rende cogliendo ogni
pretesto per presentarsi come la mia antitesi, umana e professionale.
22 novembre 1977; Confronto fra me e Bocca a Match, la rubrica
televisiva di Arbasino. Cerchiamo invano qualche motivo di litigio, e
Arbasino si arrabbia. Bocca non trova altro da rimproverarmi che il
solito articolo contro la Cederna.
Stefano Poma
http://www.luniversale.com/?p=451&fb_source=message
-